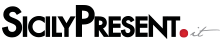Papa Francesco nel corso della sua vista a Palermo ha rivolto in Cattedrale un discorso al clero, ai religiosi e ai seminaristi. Abbiamo incontrato il 13 ottobre quattro seminaristi del Seminario di Palermo ai quali abbiamo chiesto di reagire a quanto hanno ascoltato dal Pontefice.
Domanda. Dite, dopo una breve presentazione, qual è stata la frase, il concetto, la parola che più vi ha colpito del discorso del Papa?
Angelo. Io provengo dalla Diocesi di Trapani, ho trent’anni, sono al V anno di Seminario e proprio oggi inizierò un servizio molto bello in una unità pastorale ai confini della Diocesi costituita da tre parrocchie: Marausa, Palma e Marina Grande. A me ha colpito la condanna del clericalismo. Credo che sia il perno del magistero di papa Francesco, perché quando parla ai preti lo ripete sempre. A Palermo è stato ancora più esplicito perché ha affermato: “Non abbiano cittadinanza in voi atteggiamenti altezzosi, arroganti o prepotenti. Per essere testimoni credibili va ricordato che prima di essere preti siamo sempre diaconi; prima di esser ministri sacri siamo fratelli di tutti, servitori”.
Daniele. Io frequento il V anno della Facoltà teologica, vengo da Misilmeri, da una esperienza ecclesiale svolta prevalentemente in parrocchia e da domenica scorsa ho iniziato la mia esperienza pastorale nella Parrocchia di Mater Ecclesiae a Palermo. Del discorso di quel pomeriggio mi risuona ancora oggi il verbo accompagnare. Mi è piaciuto come il Papa ha impostato la questione, e cioè partendo dal vero primo compagno che è Gesù e che noi impariamo a essere accompagnatori da Lui, che è il primo accompagnatore. Anzi, ha detto precisamente: “Accompagnare è la chiave di volta dell’essere pastori oggi. C’è bisogno di ministri che incarnino la vicinanza del Buon Pastore, di preti che siano icone viventi di prossimità”.
Domanda. Papa Francesco si rifà spesso alla metafora del Buon Pastore. A te che effetto ha fatto?
Daniele. Mi ha molto interrogato perché il richiamo al cammino da fare insieme, implica una partecipazione, una capacità di essere guida, ma non a tutti i costi, cioè indicando subito la meta, ma mettendosi accanto, soprattutto con chi ha difficoltà a trovare la propria strada. Ed in questo senso il richiamo a don Pino Puglisi, che sul serio si è fatto compagno a quanti ha incontrato, è stato prezioso. Mi colpisce sempre sentire coloro che lo hanno conosciuto personalmente quando raccontano come lui era capace di essere compagno a tutti. Il Papa ha detto: “Pensiamo a don Pino, che verso tutti era disponibile e tutti attendeva con cuore aperto, pure i malviventi.”
Gaetano. Io ho 31 anni, sono al V anno di Seminario e da due anni presto il mio servizio pastorale nella parrocchia di Sant’Ernesto a Palermo. Quello che maggiormente mi ha toccato dell’intervento di papa Francesco è il riferimento ad essere uomini del perdono. Precisamente lui ci ha detto: “C’è una seconda formula sacramentale fondamentale nella vita del sacerdote: «Io ti assolvo dai tuoi peccati». Qui c’è la gioia di donare il perdono di Dio. Ma qui il prete, uomo del dono, si scopre anche uomo del perdono”. Questa frase è legata all’altra parola: celebrare. Tra non molto io sarò chiamato ad amministrare il sacramento della riconciliazione, cioè del perdono, ma ciò sarà possibile se per primo sarò uomo del perdono. Sono rimasto molto colpito quando il Papa ha fatto riferimento a preti che portano rancore, che vivono gelosie.
Domanda. Perché? In Seminario non è così?
Gaetano. I nostri educatori in Seminario insistono molto sul sentire comunitario. Questo è uno stile che ho appreso e che cerco di assimilare sempre di più perché questo è un fatto concreto, non è qualcosa di ideale. E sicuramente questo linguaggio esortativo del Papa incoraggia davvero e cerca di rimuovere tutti quegli ostacoli che non ci fanno testimoniare la bellezza di appartenere a Cristo. Bello quello che ci ha detto in proposito: “La gente cerca questo nel prete e nei consacrati, cerca la testimonianza. La gente non si scandalizza quando vede che il prete “scivola”, è un peccatore, si pente e va avanti… Lo scandalo della gente è quando vede preti mondani, con lo spirito del mondo.
Mario. Io vengo dalla Diocesi di Ragusa, e sono al secondo anno di Seminario e degli studi teologici. La mia vocazione è nata nella mia parrocchia di Comiso. Lì ho vissuto una esperienza significativa di comunità come famiglia. Tra le esperienze fondamentali c’è stato il servizio svolto nell’Azione Cattolica. Prima di entrare in Seminario ho conseguito la laurea triennale dell’Accademia delle Belle Arti. Quest’anno svolgerò il mio servizio col gruppo di “Palermo 15” degli scout nel quartiere palermitano del Capo. Anche a me del discorso del Papa ha colpito la prima parte e il riferimento al verbo celebrare, più che altro nella accezione del dono, in particolare quando ha detto: “Le parole dell’Istituzione delineano allora la nostra identità sacerdotale: ci ricordano che il prete è uomo del dono, del dono di sé, ogni giorno, senza ferie e senza sosta. Perché la nostra, cari sacerdoti, non è una professione ma una donazione; non un mestiere, che può servire pure per fare carriera, ma una missione”.
Domanda. Questo richiamo a non fare del sacerdozio una professione, che valore ha per uno che non è ancora sacerdote?
Mario. Lui è partito dalle parole dell’Ultima Cena: “Prendete e mangiate”, cioè dal dono più importante che ci ha lasciato. Per me, queste parole del Papa sono state un ritorno alla riflessione sul senso della vita donata del presbitero che fin dal propedeutico ho sviluppato. Riconoscersi prima di tutto i destinatari di un dono, aiuta a non concepirsi come funzionari, ma come prete tra la gente, uomo tra gli uomini e testimoniare con la vita il dono ricevuto.
Domanda. In quello che finora avete detto, il verbo accompagnare è risuonato più volte. Ma che significa farsi compagnia in Seminario in un contesto che può apparire più facile rispetto ad altri?
Gaetano. A me viene subito in mente il termine fraternità e subito dopo un altro: bellezza, oltre che fatica. Dico subito che farsi compagnia, essere compagno degli altri, è faticoso, però è bello, perché sperimento quanto io ho bisogno della comunità e quanto la comunità ha bisogno di me.
Daniele. Credo che a quanto detto da Gaetano si possa aggiungere il termine comunità. Sempre ci viene ripetuto che dobbiamo essere comunità già in Seminario perché così impariamo a fare comunità lì dove il Signore ci manderà. Questa è sicuramente una sfida perché non si può non tener conto delle diversità che esistono già tra di noi. Anche noi quindi ci incontriamo e ci scontriamo quotidianamente con la diversità. Posso dire che per me tutto dipende dall’accettare che tutto, anche la diversità, è un dono e non è un ostacolo. So di dire una cosa difficile, ma il fatto che l’altro ci sia, ed è come è lui, e non come vorrei io, significa mettersi in gioco consapevoli di raccogliere i frutti alla fine della strada percorsa. È chiaro anche per me che la comunità presbiterale di domani la costruiamo qui a partire da oggi.
Domanda. Proseguendo su questo tema chiedo se possibile raccontare qualche esempio di come ci si fa compagnia in seminario.
Angelo. Ascoltando la domanda mi è venuta in mente una frase che ripete spesso mia madre: “Tutto il mondo è paese”. Lo dico nel senso che chi è fuori pensa che varcando queste mura potrebbe incontrare il paradiso in terra, angeli e santi che si rincorrono e nessuna difficoltà nei rapporti. Ed invece anche tra queste mura si riscontra e si sperimenta la concretezza delle relazioni umane. Con gli anni si arriva poi a capire che ogni relazione è unica e nel contesto comunitario è indispensabile relazionarsi con ogni persona in maniera diversa e di volta in volta è come imparare un’arte. Così come fanno gli artigiani è possibile tirar fuori da ogni persona una relazione unica, però senza la pretesa di cambiare o di dover cambiare l’altro.
Domanda. Quindi anche voi vivete una difficoltà nei rapporti con i compagni di Seminario?
Angelo. Certamente sì, è inutile negarlo. C’è un rischio da evitare: quello di chiedere scusa per evitare il disagio che deriva dalla difficoltà del rapporto. Così facendo si evita il lavorio interiore che porta all’ascesi. Non bisogna quindi scandalizzarsi che con una persona possa esserci una relazione piena e profonda e con un’altra un rapporto più formale. Ma ciò che conta in entrambi i casi è che ci sia sempre un cammino, un’apertura verso il comune destino.
Domanda. A questo punto sorge spontaneo chiedere: ma che differenza c’è tra perdono e misericordia, per esempio come la intende papa Francesco?
Angelo. Il perdono è qualcosa che possono dare gli uomini, la Misericordia è un’attitudine di Dio che cambia il cuore umano. In altri termini io non posso cambiarmi il cuore da solo, questa è un’opera di Dio da invocare certamente nella preghiera. Ecco perché è importante riconoscere il valore della Grazia. La Grazia viene prima perché è dono di Dio, non è frutto del mio impegno. Questa è l’esperienza che si fa con i bambini quando sono “irrequieti” a causa del contesto in cui vivono.
Domanda. E ad un bambino così cosa si dice? Cosa si propone?
Angelo. Bisogna dargli le necessarie attenzioni in modo che nel rapporto sperimenti quella paternità che magari non ha potuto vivere nel contesto difficile da cui proviene. In altri termini: non bastano i buoni propositi perché con questi non si cambia né il mondo né la nostra persona. In termini filosofici si può dire che l’agire segue sempre l’essere. Chi cambia il proprio cuore può mutare il proprio comportamento, chi si sforza di cambiare, presto o tardi si stanca e smette.
Mario. A me questo discorso della Misericordia e del perdono fa pensare agli episodi narrati nel Vangelo, relativi a Zaccheo, alla Maddalena, ecc. È gente che prima viene amata dal Signore e da questo amore nasce in loro il desiderio di cambiare, non viceversa. La consapevolezza che sei voluto bene dal Signore a prescindere da ciò che sono o sono capace di fare deve diventare il nostro stile di vita. E torno al discorso che ci ha fatto il Papa quando ci ha riproposto la figura di Pino Puglisi. Leggo cosa ha detto: “Pensiamo ancora a don Puglisi che, più che parlare di giovani, parlava coi giovani. Stare con loro, seguirli, far scaturire insieme a loro le domande più vere e le risposte più belle. È una missione che nasce dalla pazienza, dall’ascolto accogliente, dall’avere un cuore di padre, cuore di madre, per le religiose, e mai un cuore di padrone... La pastorale va fatta così, con pazienza e dedizione, per Cristo e a tempo pieno”. Aggiungo che non si può diventare sacerdoti da soli e non si può essere sacerdoti da soli. Al mio paese si dice che “uno solo non è buono neppure per il Paradiso”. Ed io lo riscopro sempre più vero. L’esempio del bambino che abbiamo fatto prima è chiaro: più che dare regole e rimproveri è bisogna volergli bene, perché questo è quello di cui ha veramente bisogno.
Domanda. Più volte, seppur in sottofondo, avete fatto riferimento alla fede. Qual è il rapporto tra la vostra vita, come l’avete descritta finora, e la fede? Cosa aggiunge la fede alla vostra esperienza umana e di fraternità?
Gaetano. Penso che la fede sia il cardine della fraternità, perché è vero che si può essere fratelli senza vivere una dimensione di fede, ma qui in Seminario abbiamo in comune la stessa fede, mangiamo lo stesso Pane eucaristico perché guardiamo insieme verso Gesù.
Daniele. Credo si possa declinare la fede in una duplice dimensione. Quella verticale mi riporta alla memoria l’icona dei discepoli di Emmaus. La compagnia itinerante dei due era ferita dagli avvenimenti accaduti e culminati con la presunta sconfitta del Golgota. I due si ritrovano solo quando si accorgono che il Signore cammina fra loro. Tradotto nella nostra esperienza possiamo dire che noi qui siamo insieme non per qualche progetto o ideologia, ma perché un Altro ci ha messo insieme e cammina con noi ogni giorno. La fede declinata orizzontalmente si può definire fiducia. Nella sfida del cammino comune bisogna allora buttarsi perché non tutto è chiaro. Bisogna avere fiducia che l’altro non è un ostacolo o un nemico, ma è una opportunità, così per come è, per crescere, non per conseguire obiettivi personali.
Domanda. Torniamo adesso alla questione da cui siamo partiti: il clericalismo. Che significa per voi oggi? Che significa per chi ancora non ha assunto l’abito clericale, ma si prepara a farlo? Si può essere clericali anche in seminario?
Angelo. Il prete non smette mai di essere parte del popolo di Dio; il nostro servizio sacerdotale è in funzione di quello battesimale. Se uno dei due aspetti eccede sull’altro nascono le complicazioni, cioè nasce una creatura sformata. In questo modo io capisco il continuo richiamo del Papa alla persona di Gesù Cristo, che certo non era un clericale.
Gaetano Clericalismo è l’atteggiamento che può assumere il sacerdote nei confronti delle persone che si traduce in atteggiamenti di superiorità, di sentirsi più santi, più perfetti, avocare a sé certi privilegi.
Angelo. A me viene in mente un mio compagno che a tal proposito usava l’espressione “i diritti di stola”, cioè accampare diritti, soprattutto quello di decidere da solo e non tener conto degli altri. Questo tipo di diritto non viene da una legge, ma da una presunzione, quella di essere un qualche modo diverso e migliore degli altri, una sorte di linea diretta con Gesù Cristo con cui giustificare ogni scelta senza sottoporla al vaglio dei fratelli.
Gaetano Va detto però che pur in presenza di esempi di clericalismo ci sono tante esperienza sacerdotali che brillano e che in tal modo aiutano tutti, anche i laici. Ecco perché è sempre bene avere uno sguardo più ampio e saper guardare agli esempi luminosi che esistono.
Domanda. Perché a vostro avviso Pino Puglisi non era clericale?
Daniele. Credo perché interpretava il suo appartenere alla Chiesa non come un fatto individuale, cioè non era un battitore libero, né aveva la pretesa di essere migliore degli altri, cioè viveva il suo ministero come perfettamente inserito nella sua Chiesa. Basta per tutto un esempio: il suo rapporto con Cardinale Pappalardo. È molto bello quello che ha detto il Papa: “Don Pino strappava dal disagio semplicemente facendo il prete con cuore di pastore. Impariamo da lui a rifiutare ogni spiritualità disincarnata e a sporcarci le mani coi problemi della gente”.
Domanda. In una realtà più provinciale, come quella ragusana, che connotazioni ha questo problema?
Mario Quello che accade più spesso è che i fedeli in parrocchia senza la presenza fisica del parroco si sentono incapaci di fare alcunché e di prendere alcuna iniziativa, soprattutto per le iniziative di catechesi. Certo, talvolta dipende anche dai sacerdoti che fanno fatica a responsabilizzare i laici, ma anche i laici preferiscono non assumere responsabilità dirette perché non si sentono pienamente formati a svolgere questo o quel servizio, a rivestire una qualche responsabilità.
Domanda. Come si fa a non essere clericale nel percorso di formazione al sacerdozio? Cioè in seminario?
Gaetano. Quando svolgo il mio servizio per esempio con i laici in parrocchia comprendo che bisogna avere sane relazioni e mettersi a servizio di tutti. Far percepire all’altro che hai davanti, che la sua storia e la sua vita ti interessano, sono importanti per te; insomma fare un cammino insieme, senza assumere atteggiamenti di superiorità.
Mario. Vorrei aggiungere che se il prete rientra sempre più nella sua identità di “Padre” questo rischio del clericalismo può evitarlo meglio; cioè se il parroco si sente e fa il “Padre” evita il rischio del funzionalismo rivolto ai servizi da rendere ai fedeli e evita di concepire i collaboratori come manodopera, indipendentemente dalla vita e dalle situazioni che vivono.
Domanda. E come si fa ed essere “Padre” in una parrocchia in cui non ci si può sottrarre dal dare i servizi che tutti chiedono?
Mario. Secondo me questa paternità passa attraverso cose semplici, cioè una normalità di rapporti umani da cui si comprenda l’interesse che si ha per l’altro, cioè per la sua vita, indipendentemente dal servizio che rende. Insomma passa più da una telefonata fatta con affetto che da una riunione gestita bene. La paternità passa attraverso uno sguardo, un gesto, al di là delle attività pastorali che bisogna fare più o meno bene. Mi è piaciuto molto il riferimento alla vita parrocchiale che papa Francesco ha fatto: “Crescere insieme in parrocchia, seguire i percorsi dei giovani a scuola, accompagnare da vicino le vocazioni, le famiglie, gli ammalati; creare luoghi di incontro dove pregare, riflettere, giocare, trascorrere del tempo in modo sano e imparare a essere buoni cristiani e onesti cittadini. Questa è una pastorale che genera, e che rigenera il prete stesso, la religiosa stessa”.
Angelo. Direi con mie parole così: rispettare il ministero degli altri. Il prete è visto spesso come un tuttologo, soprattutto in parrocchia. Ecco, paternità non coincide con tuttologia, ma con animazione, con promotore di attività, ma soprattutto di personalità adulte nella fede. In tutto ciò avendo molto rispetto dei compiti, dei servizi e delle competenze degli altri, con l’obiettivo di manifestare la paternità di Dio. Non bisogna avere la preoccupazione di risolvere situazioni, ma di far vedere l’amore del Padre. Il resto è solo, accompagnamento, pazienza e, se necessario, silenzio. Insomma: il nostro compito è concimare e attendere il tempo per la crescita.
Domanda. Il Papa ha fatto riferimento anche alla pietà popolare. Quanto aiuta e quanto è un fatto solo di cronaca? Nella lettera dei Vescovi siciliani in occasione dei 25 anni dal discorso di San Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi si dice: “Dobbiamo tornare a preoccuparci e a occuparci della pietà popolare, interpretandola non solo fatto sociale ormai anacronistico, bensì come fatto interno alla vita della comunità ecclesiale”. Come giudicate tutto ciò alla luce della vostra esperienza?
Daniele. Io provengo da una realtà di paese dove la fede si esprime anche attraverso la pietà popolare. Quindi prima di ogni critica bisogna riconoscere l’importanza che essa ha avuto e che ha anche oggi. Pensiamo a tutte le generazioni che ci hanno preceduto cui il Vangelo è arrivato proprio attraverso la pietà popolare. La tradizione legata ai tempi passati ha certamente funzionato. Oggi la situazione è cambiata, ma rimane il fatto che nelle realtà popolari le Confraternite hanno ancora una capacità di attrattiva sui ragazzi.
Domanda. E questo come si spiega?
Daniele. Innanzitutto col fatto che indica un desiderio di appartenenza ad una comunità che non è fondata su disvalori e che in qualche modo si richiama al Vangelo. Poi però bisogna fare in modo che questo non rimanga un fatto sociologico, ma bisogna aiutare tutti a riconoscere che c’è un collante che unisce che è Gesù Cristo, ma non nella sua dimensione spirituale, ma in quella concreta dell’esperienza. Insomma non possiamo cadere nell’equivoco che tutta la pietà popolare sia contigua alla mafia e si racchiude negli “inchini” delle statue durante le processioni.
Gaetano. Devo ammettere che quando sono entrato in Seminario avevo una concezione negativa della pietà popolare. Non provengo da ambienti popolari e il mio incontro con Cristo è avvenuto attraverso la Scrittura, attraverso la parrocchia, attraverso i rapporti. Nell’Esortazione Apostolica Evangeli Gaudium c’è un richiamo specifico sulla pietà popolare e davvero dalla sua lettura ho capito il suo valore come canale di evangelizzazione, soprattutto negli ambienti in cui si respira “un’aria scaramantica”. La pietà popolare può essere un canale di dialogo verso questo mondo.
Mario. Nella diocesi di Ragusa, la vita è ancora molto scandita dalla pietà popolare, innanzitutto dalle feste religiose e da altri momenti scaturiti dall’esercizio da essa. Questa realtà, contrariamente a quanto si pensa, non è fatta solo di anziani, ma vi prendono parte anche molti giovani che giungono all’esperienza ecclesiale della parrocchia attraverso fatti organizzativi, quali le feste. In questi casi bisognerebbe coniugare il verbo accompagnare con quello dialogare, perché questo appiglio diventi un rapporto più stretto con queste persone. Non dimentichiamo, infatti, che soprattutto nei paesi la parrocchia è uno dei punti di aggregazione dei giovani, e l’esperienza del lavorare insieme per organizzare una festa, o fare parte di un comitato o un gruppo di portatori di un simulacro o di una Confraternita produce comunque identità e voglia di stare insieme. In poche parole si può dire che bisogna utilizzare queste esperienza per farne momenti di evangelizzazione.
Angelo. La chiesa trapanese vive esperienze di pietà popolare profondamente diverse. Tra i paesi interni e Trapani città c’è in tal senso molta diversità. Io vengo da Trapani e lì tutto si racchiude e si esprime nella processione de “I misteri”. Di essa si è detto e si può dire tutto, ma è indubbio che è un momento di grande unità di tutta la città che cerca di vivere quella nottata con grande sentimento. È però significativo che questo evento di grande unità accada attorno al ricordo della Passione di Nostro Signore e non alla vita di qualche Santo. Come direbbe don Giussani: siamo di fronte ad una espressione del senso religioso.
Domanda. Per concludere: ciascuno provi a dire in una frase sintetica il senso di quanto ci siamo detti.
- “I sacerdoti sono scelti tra il popolo ma fanno parte del popolo”.
- “Siamo Chiesa oggi ma tra gli uomini di oggi”
- “Siamo chiamati ad essere veri, autentici senza maschere”.
- “Ringraziamo per quello che siamo e attraverso il ringraziamento impegniamoci per cambiare”.