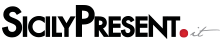Ecco, allora, che assieme alle parole della poesia e della narrativa, che ascoltiamo nel silenzio della lettura, sono ascoltate anche le parole che si lasciano dire diversamente, magari col sostegno della musica nella canzone d’autore, o nella gestualità corporea dell’attore e nei passi di danza sulle scene teatrali, le quali diventano come delle pagine tridimensionali in cui pure il silenzio può finalmente essere detto, svelandosi anch’esso gravido di invocazioni e rivendicazioni. E, così, proprio il silenzio, che non è assenza di parole, ma sforzo teso a sentire, disponibilità a udire, può essere sperimentato se non come un punto interrogativo, almeno come una serie di puntini di sospensione che indicano che si può dare pure un’altra prospettiva in cui cercare risposte alle nostre domande.
Perciò conviene lasciarsi incalzare da altri modi di formulare le domande, tese nello spasmo di sprigionarsi dalla materia di cui è fatta la scultura, o a urlare nei colori di un dipinto. O cifrate in una scrittura-altra, impastata di luce e incisa con un click, simbolo questo delle metamorfosi moderne della techné, dell’arte cioè tradottasi in tecnica, della tecnica stessa funzionale alla produzione artistica, utile per interrogare i volti degli uomini, le architetture da loro costruite e le città in cui abitano, non meno dei paesaggi naturali. E per registrare le domande che vengono ingigantite quando il click si trasforma in ciak, quando cioè la fotografia entra in un orizzonte ancor più vasto e complesso, quello cinematografico.
Proprio l’ambito cinematografico sembra oggi l’espressione di quell’arte totale che si ha quando interloquiscono differenti linguaggi artistici. Nel corso del sec. XX non sono mancati artisti che hanno installato il loro scrittoio dentro il loro atelier, maneggiando insieme il pennello e la penna (si pensi ad autori come Carlo Levi e Alberto Savinio). Ma è sul set cinematografico che i linguaggi si ibridano definitivamente: la prosa riscritta in sceneggiatura e la poesia trasfusa nelle immagini; l’immagine, a sua volta, appoggiandosi ormai ad una colonna sonora, la pittura traducendosi in fotografia e la fotografia movimentandosi in sequenza filmica; la plasticità scultorea sgranchendosi in recitazione, in danza persino e questa confluendo nel musical assieme al canto, in una totalità in cui le arti sono tenute insieme con gli artifici della tecnica.
Per rievocare questa ricchezza espressiva, nella brochure del convegno è riprodotta una fotografia scattata sul set del Vangelo secondo Matteo (1964) di Pier Paolo Pasolini, accompagnata da un verso dello stesso autore tratto dalla sua lirica Crocifissione (1948-49): «tremando d’intelletto e passione». È noto, infatti, come Pasolini abbia realizzato nelle sue opere cinematografiche l’efficace commistione di diversi generi e linguaggi, citando i capolavori di altri autori e, anzi, “riscrivendo” ciò che degli altri autori andava riprendendo. Nel Vangelo secondo Matteo, per esempio, è importantissimo l’uso ch’egli fa della Matthäus Passion di Bach, con cui già aveva sostenuto il “povero cristo” protagonista del suo primo film, Accattone (1961). La musica bachiana conferisce calore esistenziale al bianco-nero di quei film, enfatizzando implicitamente la portata sociale e politica, etica soprattutto, in un certo senso anche “profetica”, delle istanze radicali che Pasolini mette in campo rievocando la vicenda del Maestro di Nazaret e degli altri miseri cristi incontrati nel secondo dopoguerra nelle periferie romane. Come, per altro verso, la storia dell’arte rinascimentale – su cui Pasolini aveva scritto la sua prima tesi di laurea – permette di immaginare il colore in quelle pellicole: si pensi ai tableaux vivants che, sul set de La ricotta (1963), Pasolini realizza citando alla lettera le Deposizioni di Rosso Fiorentino e Jacopo Pontormo. Così intelletto e passione concorrono a «testimoniare lo scandalo» – è il verso con cui si conclude la già citata Crocifissione pasoliniana – per eccellenza, quello della morte dell’uomo pienamente, veramente, semplicemente uomo.
Forse è proprio alla maniera di Pasolini che gli artisti assoluti del passato – capaci di esprimere, come Michelangelo, il loro estro in virtù di una geniale glossolalia estetica e, perciò, di parlare al contempo diversi idiomi artistici, dalla poesia alla pittura, dall’architettura alla scultura, tutti amalgamati in una koiné che cominciava a essere già quella scientifica della modernità, da Leonardo applicata al progetto di quei suoi prototipi che anticipavano la civiltà meccanica – oggi reinterpreterebbero i vari profili del Vitruviano e troverebbero per lui nuove posizioni, mostrando inedite possibilità per far quadrare il cerchio a partire dall’uomo e in vista dell’uomo: questo sempre, comunque, raffigurato a braccia aperte e ritto sulle gambe, nella forma del Crocifisso.