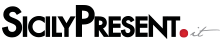(10 marzo 2015) – «Don Pino lo vedevi spesso in corridoio. Era uno che stava poco in sala professori, diceva che la sala professori “era troppo piena di professori”, con il loro sapere. Lui amava stare nei corridoi. Perché la vita in una scuola, la “vera” vita, si consuma nei corridoi. È lì che i ragazzi commentano le lezioni, dicono frasi che non è possibile ridire in classe; è lì che vengono fuori i dubbi e le domande vere, le gioie e le paure […].Quante domande celate albergano nel cuore d’ognuno! Nei corridoi c’è un’apertura dell’io ferito, finalmente disposto a parlare. Ed è lì che don Pino stava, proponendosi semplicemente come disponibile interlocutore di quelle domande, con un sorriso sempre presente. Portava sul volto la tensione di una vita impegnata e provata, ma aveva una serenità di fondo. Come il mare quando è in tempesta, ma pochi metri sotto è calmo […]. Un sorriso che ha mostrato al mondo che la felicità non deriva dall’allungare la vita ma dall'ampliarla»
Sabato 7 marzo Alessandro D’Avenia iniziava così la sua conversazione con centinai di allievi di vari licei della Sicilia occidentale, radunatisi al teatro Golden di Palermo per ascoltare la presentazione del suo terzo e ultimo romanzo Ciò che inferno non è. D’Avenia si presenta fin da subito come un professore un po’ sui generis: entra sul palco tra le acclamazioni e gli applausi dei ragazzi, tanto che viene naturale chiedersi se ci si trova dinnanzi ad un uomo di lettere o ad un novello attore di fiction.
Al suo ingresso si rimane col dubbio – forse un po’ pregresso e pregiudizioso – se il suo successo sia frutto di una “moda” letteraria che imperversa tra i giovani o sia davvero legato alla sua ars dicendi e a quel che vi è al fondo; se a conquistare siano i suoi larghi occhi chiari e la sua capacità di farsi ben volere dagli adolescenti o i contenuti. Finché, appunto, non prende la parola.
Il giovane scrittore sceglie di condurre l’incontro non dietro la scrivania preposta (scongiurando il pericolo di ricordare alla maggior parte dei presenti in sala una lectio ex cattedra), ma dialogando seduto innanzi ad essa, guardando sempre con la coda dell’occhio i propri genitori e la sorella Marta in prima fila. E, soprattutto, esordisce non parlando di sé e del proprio romanzo, ma raccontando di quel sacerdote un po’ strano che i ragazzi a Palermo conoscono affettuosamente come 3P, che era stato l’insegnante di religione dei suoi due fratelli più grandi e da lui più volte incontrato da ragazzo tra le aule del liceo classico Vittorio Emanuele II.
D’Avenia parla, dunque, in prima battuta di don Pino Puglisi, di quel suo sorriso pacificato che aveva il potere d’illuminare dolcemente e senza rumore la vita di chi gli stava di fronte, se questi non se ne sottraeva volontariamente. «Se sorridi a qualcuno – afferma - gli stai dicendo che la sua è una vita che merita di essere servita, che la sua vita è uno spazio che va difeso. Si sorride di fronte a un dono, ad una sorpresa. Quando io parlo di “sacrificio” di don Pino non parlo solo della sua morte, ma di quel “sacrum facere”, di quella capacità di rendere sacra la vita degli altri». D’Avenia propone ai liceali di oggi il sorriso di don Pino come parte di una delle due strade alternative che chiunque di noi ha nella realtà di tutti i giorni: o ampliare il mondo o restringerlo. Prospetta la possibilità di scegliere se ampliare con la propria vita la vita degli altri oppure decidere di diminuirla perché in fondo si ha già diminuito la propria. “Ridurre il mondo” vuol dire, per lo scrittore, fare come quel l’insegnante di un liceo milanese che il primo giorno di scuola, trovandosi davanti trenta ragazzi del primo anno con gli occhi sgranati e i volti in attesa, prima ancora di averli conosciuti, non trova altro da dire loro che «siete troppi, vi diminuiremo». L’alternativa a questo è “allargare il mondo”, “sorridere”. Un sorridere che non passa obbligatoriamente dal mostrare i denti, ma è il coraggio di disancorarsi dalla propria misura ridotta e abbracciare la realtà.
Il giovane professore-scrittore ricorda a tutti che lo spazio di “ampliamento” del mondo è dato in ogni giornata e tocca a ciascuno scegliere. A chi gli chiede perché, sebbene il titolo del suo romanzo riecheggia l’ultimo passo delle “città invisibili” di Calvino, dell’autore delle “lezioni americane” nel testo non vi è più nemmeno l’ombra, D’Avenia risponde disinvolto che ad averlo distolto da una condivisione piena del pensiero calviniano sia stata l’idea sottesa in quest’ultimo che l’origine dell’inferno sia “esterna ed estranea” a noi stessi e di aver preferito premettere al suo romanzo una citazione di Dostoevskij proprio per sottolineare che lo spazio vero della battaglia tra “l’allargare” e il “restringere” la vita è, invece, per ognuno, il proprio cuore.
Parla ai ragazzi della possibilità quotidiana che avvenga qualcosa che cambi i loro piani e stravolga l’esistenza. Propone loro la possibilità che accada nella vita un incontro apparentemente casuale che li porti in strade mai percorse e li spalanchi al reale, proprio come è avvenuto a Federico il protagonista di quest’ ultimo suo romanzo che, mentre si preparava a partire per una vacanza-studio a Oxford viene invitato da 3P a dargli una mano con i bambini del quartiere Brancaccio.
Federico scoprirà, a partire dall’incontro con don Pino, che la propria vita è chiamata ad un’“altezza”, che la realtà tutta chiama ad un altezza. Parimenti D’Avenia, in un teatro pieno di studenti di licei, afferma che l’adolescenza è l’età principale per entrare a contatto con la propria “vocazione” e paragona quest’ ultima ad un semino, ad un germe che va protetto e difeso; ricorda che la vita è rispondere a qualcuno che ci chiama per nome, come durante l’appello a scuola. Fa riflettere sul fatto che, se in aula si volesse rispondere in latino all’appello, al posto di “presente” bisognerebbe dire “ad-sum” e il preverbo manifesterebbe già l’idea di una direzione, di un moto a luogo; perché il fatto stesso di “esserci”, di esistere è tensione verso qualcosa e ciascuno è fatto per un qualcosa di grande da realizzare in un modo unico, come unica al mondo è l’impronta digitale del proprio indice.
I ragazzi lo ascoltano e si lasciano provocare. Alla fine della conversazione sono decine ad alzarsi per porre domande e fare interventi. Ad una ragazza che gli chiede come tenere desto “il sentirsi fatti per qualcosa di grande” vivendo in una società che, in varie forme e misure, tende a fartelo dimenticare, risponde con semplicità di non farsi toccare dal male di chi sostiene il contrario, perché «il male è loro e non tuo», di non lasciarsi avvelenare e anestetizzare il cuore. La invita a trovarsi una compagnia di amici che sappiano riscaldare nuovamente questo cuore quando la fiammella della Bellezza si spegne: «Dante scrive il Convivio – afferma – perché è cosciente che la Bellezza va abitata, consumata. Vatti a cercare coloro che sono capaci di ricreare in te questa Bellezza, persone che hanno pane buono da condividere». I professori presenti, infine, vengono invitati a non scoraggiarsi se non vedono i“frutti” immediati delle fatiche del proprio lavoro perché «chi semina datteri non mangia datteri» ed esortati a fidarsi più della propria capacità di amare che non della risposta dei ragazzi.
Da parte di chi scrive, lo si voleva fare più “serioso” e analitico il resoconto di una conferenza di presentazione di un romanzo – da bravi uomini (e donne) di lettere – ma si è posta anche qui un’alternativa: o guardare distaccati lo strano “caso D’Avenia”, studiare la fenomenologia di uno scrittore che è riuscito in pochissimi anni a conquistare l’animo dei più giovani, presentare i passaggi del testo e analizzarne le progressioni e i cambiamenti stilistici rispetto ai romanzi precedenti oppure lasciarsi toccare il cuore e ricordare che c’è un modo di guardare il proprio lavoro e la propria vita che ne fa un avventura appassionante, financo dentro la “precarietà” della scuola italiana.
Come ricorda Pigi Colognesi «la grandezza, diceva Albert Camus, arriva come un bel giorno; un giorno che sembrava uguale a tutti gli altri. Non dipende da noi. A noi tocca non essere distratti nella rincorsa affannosa di un diverso che ha solo la faccia esteriore del nuovo. A noi tocca avere gli occhi sufficientemente aperti per accorgersene». A noi tocca lasciare spazio e invitare gli altri a lasciare spazio a “ciò che inferno non è”.