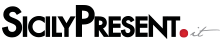(24 dicembre 2015) – Qualche giorno fa ha concluso i suoi studi alla Facoltà Teologica di Sicilia conseguendo il Dottorato in Sacra Teologia don Lucien Tobochiandou, sacerdote del Benin che dal 2007 è in Sicilia per completare i suoi studi. Ha trascorso gran parte di questi anni a Palermo, nella parrocchia di sant’Ernesto ove ha svolto la sua missione pastorale, collaborando con i parroci che si sono succeduti. Prima di lasciare la Sicilia e tornare nella sua diocesi di Abomey gli abbiamo chiesto un racconto e un giudizio su questi anni.
Don Lucien come mai è venuto a studiare in Italia e in particolare a Palermo?
Tutto è scaturito dall’incontro di due esigenze. Quella di don Giuseppe Bucaro, che in quel periodo era parroco di sant’Ernesto, il quale aveva chiesto al mio Vescovo, ora deceduto, se aveva dei sacerdoti disponibili per venire a Palermo e aiutarlo in parrocchia. E quella della mia diocesi che cercava un luogo in Europa ove far studiare alcuni sacerdoti. Il mio Vescovo non conosceva la Sicilia, ma solamente Roma; tuttavia volle accogliere l’invito che veniva da Palermo destinando per questa città un altro mio confratello, perché io sarei dovuto andare altrove. Poiché per varie ragioni lui non poté partire e poiché la documentazione era già pronta, fui scelto io all’ultimo momento.
Quindi lei non conosceva Palermo?
Quando mi hanno detto di andare a Palermo non sapevo nemmeno dove fosse. Ho iniziato a cercare sull’Atlante e con una certa fatica l’ho trovata.
Che esperienza aveva fatto in Benin?
Ho fatto il prete in Benin insegnando prima in Seminario e poi sono stato parroco. La Chiesa in Benin è certamente molto giovane e quindi desiderosa di dire la sua e di annunciare Cristo a tutta la società. È costituita, così come tutta la società, soprattutto da giovani, mentre qui da voi la popolazione è più anziana. Il Benin ha consolidati e antichi legami con la Francia. Questo vale per tutti i settori della società e anche per la Chiesa. Infatti, moltissimi sacerdoti vanno in Francia per svariati motivi. Anch’io sono andato più spesso in passato per brevi periodi per sostenere l’attività di alcuni parroci, ma non conoscevo nulla dell’Italia.
Quali differenze ha notato tra la Chiesa in Francia e quella in Italia?
La chiesa francese ha molti sacerdoti anziani ed una attività religiosa poco presente, poco incidente nella società. In chiesa vanno prevalentemente gli adulti. In Italia e a Palermo ho trovato una chiesa diversa, più giovane, più semplice, più desiderosa di esprimersi e di annunciare il Vangelo.
Nel novembre del 2011 in occasione della visita di Benedetto XVI in Benin lei è tornato a casa per un breve periodo, insieme al parroco di sant’Ernesto don Carmelo Vicari ed alcuni amici palermitani. Che ricordo ha di quei giorni?
È stato un gesto di amicizia e di fraternità cristiana molto significativo. Sono stato contento di aver fatto conoscere il mio Paese a questi amici e poi, se posso dirlo, sono stato contento perché sono tornati vivi.
Ma che vuol dire?
Voglio dire che per andare ci siamo sottoposti tutti a numerose vaccinazioni come prescrive la legge. Ma a me tutte quelle prescrizioni sembravano troppo rigorose. Per gli italiani era normale, ma io provavo fastidio. Mi dicevo: ma come, per andare a casa mia, dove ho vissuto tanti anni e sono sopravvissuto fino ad oggi, devo fare tutta questa quantità di iniezioni? I miei compagni di viaggio palermitani però mi hanno convinto a sostenere questa profilassi. Al ritorno ho detto loro: avete visto? Si può andare e tornare vivi dall’Africa!
E quale giudizio ne ha tratto?
C’è un breve racconto che può essere utile per comprendere. Si narra di un uomo che nella foresta vide da lontano un animale che stava su una collina. Incuriosito si avvicinò e scoprì che era un uomo. Poi si avvicinò ancora e scoprì che era suo fratello. Ecco, per conoscere l’altro bisogna avvicinarsi col desiderio di conoscere. Questo era vivo nel miei compagni di viaggio e di questo li ho sempre ringraziati.
Quale giudizio dà della sua permanenza in Italia dopo che è stato tra noi per 8 anni?
Sono venuto con una ingenuità tutta africana. Mi riferisco all’esperienza del razzismo che in Africa non esiste, per il semplice motivo che siamo tutti neri di carnagione. Invece qui l’ho sperimentata sulla mia pelle. Non perché abbia subito manifestazioni di violenza personale, ma perché fin dal primo giorno ho compreso che mentre in parrocchia, perché ero prete, venivo trattato come tutti, anzi con un certo rispetto, appena uscivo fuori, per strada, al bar, in un negozio le cose cambiavano.
Perché?
Percepivo un certo atteggiamento di rifiuto e di distacco, anche se nessuno apparentemente me lo faceva notare. In Italia è un fatto normale e non è per nulla grave, ma io ho fatto fatica ad accettare questi due modi di avere rapporti con la stessa persona, che sono io. La considerazione che avevo era legata al mio stato clericale, non alla mia persona umana. Per voi è un modo di fare spontaneo, forse senza cattiveria, ma spesso evidente. Per esempio, finché ero nel cortile della parrocchia tutti mi salutavano con rispetto. Quando uscivo a conversare all’esterno, magari con i guardiamacchine che sono neri, l’atteggiamento cambiava. Poi spesso si concludeva con una frase: “Mi scusi Padre, ma non l’avevo riconosciuto poiché era insieme con…”. Ecco, malgrado fossi sempre io, l’atteggiamento era diverso a soli venti metri di distanza.
Col passare degli anni queste difficoltà si sono attutite o si sono aggravate?
Sono diminuite di molto, anche se la diffidenza nei confronti dello straniero rimane sempre, in Francia, in Europa e in Italia. Sia chiaro, non esiste paese al mondo in cui non ci sia paura dello straniero. Ma il razzismo non deriva dal colore della pelle, ma dalle condizioni economiche. In Africa c’è un caso limite, ma esemplificativo: il Sud Africa. Da quando non c’è l’apartheid si sta diffondendo una paura e una diffidenza del bianco da parte dei neri che hanno preso la conduzione del paese. Insomma, è iniziato il razzismo anti-bianco.
Come ha vissuto e queste difficoltà in parrocchia?
La parrocchia mi ha aiutato tantissimo attraverso l’amicizia innanzitutto col parroco don Carmelo Vicari, che mi ha accolto come fratello e amico, poi con gli altri sacerdoti stranieri che via via hanno soggiornato a sant’Ernesto, e poi con coloro che in vario modo mi sono stati vicino, in modo semplice, aiutandomi a superare queste difficoltà e tante altre forse meno importanti, come per esempio la lingua; alla fine mi sono sentito pienamente uno come tutti ed ogni differenza si è smorzata.
Che giudizio dà sulla Chiesa italiana dopo l’esperienza di questi anni in Italia?
In questi anni trascorsi a sant’Ernesto mi sono sentito molto utile come prete, perché da voi la figura del prete è ancora molto importante, non solo perché amministra i Sacramenti, ma anche perché la gente vede in lui una persona cui affidare il senso della propria vita. Ciò che più mi ha impressionato, soprattutto all’inizio della mia permanenza, è stato l’impatto col problema della superstizione. Pensavo fosse solo un problema degli africani, ma non è così. Certo da voi non ha le dimensioni e l’incidenza che ha da noi, però esiste.
E quale è stato il rapporto instaurato con queste persone?
Ho capito che con queste persone ci vuole più chiarezza dottrinale, cioè fare meglio il catechismo, ma anche dimostrare con la vita, cioè facendo loro compagnia, che Gesù Cristo è la risposta a tutti i loro problemi. Altrimenti vivono credendo che per alcuni aspetti della vita la fede cristiana è sufficiente e per altri no. Mi sono fatto aiutare dalla testimonianza dei santi, presentandoli non come gente buona solo a pregare, ma come persone che hanno saputo affrontare tutti i problemi, perché il Signore è stato loro compagno nella vita.
Come è stata utile in tal senso l’esperienza maturata in Africa?
Innanzitutto ho cercato di essere disponibile all’ascolto, senza dare l’impressione che il problema non esiste. Sono persone che hanno bisogno di parlare con chi è disponibile ad ascoltarle e sappia offrire loro una parola che dia fiducia nella vita. L’esperienza africana mi ha insegnato ad essere innanzitutto equilibrato, senza assumere atteggiamenti di chiusura preventiva o di benevola accondiscendenza.
E in particolare che esperienza si porta della vita e dell’attività parrocchiale a sant’Ernesto?
Quello che più mi ha colpito è il posto centrale che occupa l’uomo in ogni attività pastorale. Ho visto che tutto gira attorno a lui. La proposta cristiana è fatta innanzitutto alla sua libertà, cioè non lo si vuole costringere in alcun modo. Gli si offrono varie possibilità di incontri, per esempio quelli che ogni settimana si svolgono in parrocchia per i giovani, gli anziani, le famiglie, gli studenti, o quelli del catechismo per i bambini, ecc. Ma questo di per sé non basta perché ho notato che senza un impegno che sia rivolto alla persona, ai suoi bisogni e alle sue domande più vere il rischio è di trasformare la parrocchia in un luogo dove si danno servizi. Insomma, la comunità cristiana non può nascere automaticamente dalle riunioni, perché l’attenzione alla persona di cui parlavo prima deve riguardate tutta la sua vita. E questo in modo speculare è uguale anche in Benin.
Perché speculare? Che vuol dire?
In Benin coloro che si convertono vengono quasi sempre da una religione tradizionale fatta di regole e precetti molto rigidi e stringenti, quindi trovano “vantaggioso” convertirsi al cristianesimo. In Italia molti pensano che il cristianesimo sia una costrizione della libertà che vivono nella società. Sarebbe come dire che la conversione in Benin garantisce una maggiore libertà, mentre in Italia la riduce. Ma il problema è lo stesso sia lì che qui, perché riguarda sempre la libertà, che non può essere intesa in termini quantitativi; cioè di cose in più o in meno da poter fare. È un problema di educazione, che è quella che richiede la fede cristiana. La libertà è ad una obbedienza, al sì da dire a Dio, non alla misura che io ho stabilito di tutte le cose.
Quale impressione si riporta a casa dei rapporti con le persone che ha incontrato?
Ci sono persone che parlano molto e fanno poco e poche persone che non parlano e fanno molto. Questa è certamente la logica della vita, ma produce come conseguenza una scarsa capacità a legarsi nei rapporto. Spesso le parole sono vuote, non producono conseguenze né in chi le ascolta né in chi le pronunzia.
Quali sono i ricordi migliori che porterà in Benin?
Non porterò ricordi, perché così come non ho vissuto il distacco dal Benin, non vivrò il distacco dalla Sicilia. Certo fisicamente tra qualche giorno tornerò nel mio paese, ma il mio cuore rimarrà contemporaneamente sia lì che qui. L’esperienza del ricordo è di chi interrompe il rapporto, ma io vivo nel presente. Per me non esiste il passato, c’è un presente che continua.
Da chi ha imparato tutto ciò?
Dal rapporto con mio padre, morto quando avevo 5 anni.
Ma come è possibile?
Il suo ricordo, quello della sua persona mi è stato trasferito da mia madre e da tanti altri che l’hanno conosciuto. Me lo hanno fatto conoscere man mano che diventavo grande ed è diventato quindi una presenza, anche se non c’era più fisicamente. Mi è stato guida e compagno nella vita e quindi da ricordo è divenuto “presenza”. Ecco perché non vivo mai di ricordi, ma per me tutto è presenza.
Come potrà continuare il rapporto con le persone che ha lasciato a Palermo?
Vedremo! Non mi interessa però che continui solo con le opere di carità, di cui il mio Paese ha pur di bisogno. Mi sta a cuore la certezza che io lì e voi qui proseguiamo sullo stesso cammino percorso in questi anni. Ma voglio dire un’ultima cosa.
Quale?
A me piace molto la discrezione cristiana. Non mi aspetto niente in particolare. Ma capirò l’efficacia del mio ministero di questi anni a sant’Ernesto da come la gente sosterà il mio cammino, non solamente per l’apporto materiale che se vuole potrà dare liberamente; da come chi rimane a sant’Ernesto ricorderà la mia testimonianza anche in mia assenza si capirà sé è passata invano.
Nella foto: don Lucien Tobochiandou con don Carmelo Vicari, parroco della chiesa sant’Ernesto a Palermo