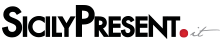Il 6-7 giugno 2012 si svolgerà a Roma il convegno Mi metto la mano sulla bocca. Echi sapienziali nella letteratura italiana contemporanea. Il convegno si terrà presso l'Istituto Luigi Sturzo (Via delle Coppelle n. 35), è organizzato dal Centro "Mons. A. Travia" per lo studio della storia e della cultura di Sicilia della Facoltà Teologica di Sicilia e della Arciconfraternità S. Maria Odigitria dei Siciliani, ed è strutturato in tre sessioni e altrettante discussioni di cui una conclusiva ( vedi il programma ). Anticipiamo l'introduzione al convegno di Massimo Naro.- Sicily Present
(5 giugno 2012) - Mi metto la mano sulla bocca: un’introduzione al convegno sugli echi biblico-sapienziali nella letteratura italiana contemporanea. Dieci anni fa la Facoltà Teologica di Sicilia e il Centro per lo Studio della Storia e della Cultura di Sicilia, sostenuto dall’Arciconfraternita Santa Maria Odigitria dei Siciliani a Roma, iniziavano un percorso di ricerca sulle cosiddette “domande radicali” che risuonano nella letteratura contemporanea. Si tratta degli interrogativi che riguardano l’esistenza dell’uomo e il senso ch’essa ha o, per taluni autori, assolutamente non ha o almeno rischia di non avere, minacciata com’è – continuamente e, anzi, inevitabilmente – dalla morte e da tutto ciò che della morte è, nella vita stessa, premessa e promessa: la malattia, il dolore e la sofferenza, la violenza dei più forti contro i più deboli, il potere abusivo, la libertà abusata, il tradimento della giustizia e la manipolazione della verità, tutte esperienze abissali da cui il setaccio della poesia e la riflessione letteraria distillano quelle che Gesualdo Bufalino chiamava appunto le «domande grandi», che persino il più piccolo degli uomini non può non porsi almeno una volta. L’interrogazione radicale, così concepita, costituisce quasi il bisturi affilato atto a incidere le piaghe del mondo per discernere se esso sia «salute oppure metastasi», ma utile anche per rovistare nelle pieghe della storia al fine di verificare se dentro vi si celi una qualche provvidenza divina oltre che, tutta intera, la responsabilità umana.
Dal 2002, seguendo questa prospettiva, s’è tenuta una serie di convegni, di cui quello del 6-7 giugno è ormai il sesto. I primi tre sono stati dedicati agli scrittori di origine siciliana, i quali, nel corso del Novecento, sono stati straordinariamente numerosi, forse più che in altre regioni italiane, e che, comunque, in gran numero hanno raggiunto la notorietà, da Pirandello a Sciascia, da Tomasi di Lampedusa a D’Arrigo, da Vittorini e al già citato Bufalino, da Borgese a Samonà, da Brancati a Consolo, da Quasimodo a Cattafi, a Piccolo, a Fiore, a Bonaviri, a Perriera e a tanti altri, così tanti che ricordarli tutti equivarrebbe a recitare una sorta di litania lauretana o le denominazioni coraniche di Dio. Il quarto convegno ha slargato il campo d’indagine, rivolgendo l’attenzione alla grande letteratura del resto d’Italia, da Svevo a Buzzati, da Carlo Levi a Silone, da Pomilio a Corrado Alvaro, da Ungaretti a Montale, da Saba a Caproni, da Pasolini a Tondelli, anche in questo caso per citarne solo alcuni. Il quinto convegno ha segnato una sorta di giro di boa, giacché – intendendo la scrittura letteraria come una «spada a doppio taglio» (Eb 4,12) – ha studiato il tema delle domande radicali in alcuni scrittori del Novecento che hanno espresso nelle loro opere i moti della loro coscienza problematicamente e, se si può dirlo, laicamente credente, e in alcuni spirituali che hanno saputo testimoniare la loro personale vicenda religiosa tramite una scrittura di “qualità letteraria”: per fare un esempio, il siciliano Fortunato Pasqualino a rappresentare i primi e don Primo Mazzolari a rappresentare i secondi.
Il convegno di quest’anno vuole approfondire proprio quest’altra direttrice della ricerca sulle domande radicali nella letteratura italiana contemporanea, registrandole stavolta come fossero “echi” di quegli interrogativi alti e puntuti che si trovano già nelle Sacre Scritture, a partire dal salmo 8, in cui l’orante biblico si chiede – mentre pure lo chiede a Dio – chi sia veramente l’uomo, attraverso tutta la cosiddetta letteratura sapienziale, di cui Qohelet è il rappresentante più famoso, per giungere al libro di Giobbe, dove le disgrazie dell’uomo di Uz preannunciano quella che nella vicenda pasquale dell’uomo di Nazareth si sarebbe rivelata anche come una misteriosa “sconfitta di Dio”, per usare le parole che compongono il titolo di un denso volumetto di Sergio Quinzio.
Gli echi sapienziali nella letteratura italiana contemporanea sono colti dai relatori del convegno nelle pagine di autori che coprono tutto il Novecento – da Clemente Rebora a Luigi Santucci, passando attraverso Guido Morselli, Cristina Campo, Bartolo Cattafi (rappresentante di un nutrito drappello di poeti siciliani vissuti prima e dopo di lui, da Virgilio La Scola ad Angelina Lanza Damiani, da Calogero Bonavia a Castrense Civello e ad altri ancora viventi, come Giovanni Occhipinti, Stefano Vilardo e, più giovane di tutti, Antonio Di Mauro), Primo Levi, Margherita Guidacci, David Maria Turoldo, Agostino Venanzio Reali e il già ricordato Sergio Quinzio – o che, come nel caso di Mario Luzi, Divo Barsotti e Alda Merini, continuano a vivere e a scrivere fino alla prima decade del XXI secolo. Non c’è una finalità sistematica a collegarli insieme, ma il desiderio di saggiare almeno in ordine sparso un territorio del resto troppo vasto per essere perlustrato con una sola incursione. D’altra parte il percorso di lettura e di interpretazione risale volutamente più a monte e prende le mosse da Giacomo Leopardi, che dei «poeti del dolore» – per citare una relatrice del convegno, Anna Baldini – è in Italia il capostipite. Si tratta di autori che condividono più che la fede in Dio la pietà per l’uomo, nel cui nome essi alzano la voce per chiedere conto e ragione – all’uomo stesso e, in ultima istanza, a Dio – di ciò che l’opprime e lo mortifica. Proprio come Giobbe, che nel libro biblico a lui intitolato si smarca dalle teodicee che da sempre tentano pelosamente di giustificare Dio ad ogni costo di fronte ai mali dell’uomo e arriva finalmente a teologare, cioè a chiederne tragicamente il perché a Dio stesso.
Il convegno si propone di far emergere la corrispondenza intertestuale fra lettera biblica e produzione letteraria, senza fermarsi tuttavia a contare le citazioni bibliche più o meno esplicite ricorrenti negli autori presi in esame, o quelle soltanto implicite nascoste nelle loro opere, bensì concentrandosi a decifrare ciò che del messaggio biblico di volta in volta, caso per caso, l’eco prolunga e deforma al contempo. Insomma, ciò che – negli scrittori studiati – è “altro” rispetto alla lettera biblica, ciò che viene rielaborato e superato nel momento stesso in cui pure è recuperato e ricordato. Si vuole capire cosa diventa – e perciò cosa forse non è più – la preghiera del salmista, la meditazione di Qohelet, il cantico degli innamorati, la protesta di Giobbe, nei versi e nelle pagine di Leopardi e degli altri autori italiani qui chiamati in causa. Ci si propone, in definitiva, di appurare una intertestualità non meramente filologica, capace di svelare piuttosto la continuità-nella-discontinuità tra lo spirito del messaggio biblico e la ricerca di senso di cui si sono incaricati i nostri scrittori.
Per conseguire questo obbiettivo occorre innanzitutto riflettere sul carattere letterario delle Sacre Scritture e, in particolare, sulla qualità poetica della letteratura biblico-sapienziale, perlustrando così un orizzonte vastissimo che già pionieri come Robert Alter e Jean-Pierre Sonnet hanno negli anni scorsi indagato con grande efficacia pur senza esaurire le possibilità esegetiche ed ermeneutiche che se ne possono ricavare. Promettente e significativa risulta in particolare, a tal riguardo, la polisemia che le parole della lingua ebraica si portano dietro e dentro come una loro dote peculiare. Se ne era accorto anche Leopardi. Nello Zibaldone, difatti, il poeta di Recanati più volte sottolineava la semplicità strutturale e persino la primitività linguistica dell’ebraico, che – mancando di termini composti – non può vantare la ricchezza semantica e la raffinatezza retorica del greco e di altre lingue antiche. Nondimeno, nella Bibbia, il deficit si traduce in chance, perché le parole si forzano a dire più di ciò che esprimono in prima battuta, nascondendo sensi traslati e metaforici, stridendo tra di loro di volta in volta negli ossimori, nei merismi e nei paradossi che trapuntano le storie d’Israele, risuonando all’unisono «riso e lagrime», per dirla come Dostoevskij nei Ricordi della casa dei morti ripreso e commentato da Santucci nel suo saggio su Poesia e preghiera nella Bibbia, come alleluia gioioso ma anche come protesta arrabbiata nei salmi e, persino, come controversa bestemmia sulle labbra di Giobbe che discute di Dio con Dio: «Or dunque – concludeva Leopardi – non potendo quasi la prosa ebraica usar parola che non formicolasse di significazioni, essa doveva necessariamente riuscir poetica per la molteplicità delle idee che doveva risvegliare ciascuna parola (cosa poetichissima, come altrove ho detto)» (Zib. 3565). Così nella Bibbia l’afasia umana, che corrisponde e forse consegue all’indicibilità divina, viene in qualche modo guarita e addirittura guadagna dignità teologica. Ciò che non si riesce a dire, ciò che non si può dire, viene comunque udito, perché quello che è scritto, nel sua spesso disadorna semplicità, risuona di tanti diversi significati. «Se non fosse ambigua / mi piacerebbe meno la parola», viene da dire, ricordando un verso di Mariaceleste Celi. «Una parola ha detto Dio, due ne ho udite», dice lo stesso salmista (Sal 62,12), quasi ad ammettere che nella Bibbia ha capacità poetica – riesce a rintracciare il senso, si fa scopritore di significati – non tanto chi s’industria a discettare di Dio e, al limite, chi s’accanisce a discutere con Dio quanto piuttosto chi sa ascoltarlo: «Mi metto la mano sulla bocca. Ho parlato una volta, ma non insisterò; ho parlato due volte, ma non aggiungerò nulla», dice esausto ma consapevole Giobbe al cospetto di Dio, ormai nel finale del suo libro (Gb 40,4-5).
Stando così le cose, la letteratura biblico-sapienziale non subisce ma, anzi, si esercita nello sforzo ermeneutico. Ha da essere compresa, certamente. Ma è pure, già essa stessa, tentativo di capire. Alla stessa stregua di quella letteratura inquirente e questuante, gravida di domande radicali, che nel convegno viene presa in considerazione. In uno dei suoi ultimi componimenti poetici, il dramma dedicato al martire palermitano don Pino Puglisi (Il fiore del dolore, 2003), non a caso Mario Luzi fa dire al personaggio suo portavoce: «Nostro mestiere è l’interpretazione». Il poeta è, sulla scorta del salmista, o del Qohelet, o di Giobbe, non colui che teorizza ideologie, ma colui che interpreta lo svolgersi del mondo e, al limite, il dirsi e il darsi di Dio nel mondo stesso, sempre restando attento a ciò che non è ovvio, a ciò che rimane non evidente, dislocato sull’«altro lato della vita», come ha scritto Cristina Campo in una pagina de Il flauto e il tappeto.
Occorre quindi riflettere anche sulla letteratura contemporanea come ri-scrittura della Bibbia, intesa (la ri-scrittura) non come mera ripresa di immagini e di suggestioni bibliche, ma come ri-comprensione di quelle immagini e di quelle suggestioni. Il tema, a partire dalla lezione di Northrop Frye sulla Bibbia «grande codice» della cultura occidentale (1981), è ormai declinato da molti studiosi, anche se talvolta in direzioni differenti. I corposi volumi curati da Pietro Gibellini e da Nicola Di Nino su La Bibbia nella letteratura italiana (2009 e 2011), sotto questo profilo, sono esemplari e costituiscono un importante punto di riferimento. Nel nostro caso, però, si tratta di nuovo di inseguire specialmente gli echi sapienziali, non solo in autori come Turoldo e Reali, i quali hanno tradotto in poesia italiana intere sezioni della letteratura biblico-sapienziale, i Salmi in particolare Turoldo e il Cantico dei cantici Reali, ma anche in autori che hanno composto nuovi salmi o nuovi cantici rivestendosi – consapevolmente o senza neppure rendersene conto – dei panni del Qohelet, o di Salomone, o di Giobbe, o persino – slittando in avanti, verso Gesù di Nazareth – mettendosi nei panni degli evangelisti, sino a proporre anche loro – come Luigi Santucci con il suo libro Volete andarvene anche voi? – un “quinto evangelio”, nelle cui pagine incontrare ancora il Christus patiens, «gran piaga verticale» in cui ognuno può ormai riconoscersi e riconoscere Colui che assume la condizione di Giobbe e grida sulla collina del Golgota la protesta del salmista: «Perché mi hai abbandonato?» (Sal 21[22]), mentre si accinge a «baciare» la morte, divenendo perciò «uomo per eccellenza», come l’ha definito Alda Merini in un verso del suo Magnificat.
Il 6-7 giugno 2012 si svolgerà a Roma il convegno Mi metto la mano sulla bocca. Echi sapienziali nella letteratura italiana contemporanea. Il convegno si terrà presso l'Istituto Luigi Sturzo (Via delle Coppelle n. 35), è organizzato dal Centro "Mons. A. Travia" per lo studio della storia e della cultura di Sicilia della Facoltà Teologica di Sicilia e della Arciconfraternità S. Maria Odigitria dei Siciliani, ed è strutturato in tre sessioni e altrettante discussioni di cui una conclusiva ( vedi il programma ). Anticipiamo l'introduzione al convegno di Massimo Naro.- Sicily Present
(5 giugno 2012) - Mi metto la mano sulla bocca: un’introduzione al convegno sugli echi biblico-sapienziali nella letteratura italiana contemporanea. Dieci anni fa la Facoltà Teologica di Sicilia e il Centro per lo Studio della Storia e della Cultura di Sicilia, sostenuto dall’Arciconfraternita Santa Maria Odigitria dei Siciliani a Roma, iniziavano un percorso di ricerca sulle cosiddette “domande radicali” che risuonano nella letteratura contemporanea. Si tratta degli interrogativi che riguardano l’esistenza dell’uomo e il senso ch’essa ha o, per taluni autori, assolutamente non ha o almeno rischia di non avere, minacciata com’è – continuamente e, anzi, inevitabilmente – dalla morte e da tutto ciò che della morte è, nella vita stessa, premessa e promessa: la malattia, il dolore e la sofferenza, la violenza dei più forti contro i più deboli, il potere abusivo, la libertà abusata, il tradimento della giustizia e la manipolazione della verità, tutte esperienze abissali da cui il setaccio della poesia e la riflessione letteraria distillano quelle che Gesualdo Bufalino chiamava appunto le «domande grandi», che persino il più piccolo degli uomini non può non porsi almeno una volta. L’interrogazione radicale, così concepita, costituisce quasi il bisturi affilato atto a incidere le piaghe del mondo per discernere se esso sia «salute oppure metastasi», ma utile anche per rovistare nelle pieghe della storia al fine di verificare se dentro vi si celi una qualche provvidenza divina oltre che, tutta intera, la responsabilità umana.
Dal 2002, seguendo questa prospettiva, s’è tenuta una serie di convegni, di cui quello del 6-7 giugno è ormai il sesto. I primi tre sono stati dedicati agli scrittori di origine siciliana, i quali, nel corso del Novecento, sono stati straordinariamente numerosi, forse più che in altre regioni italiane, e che, comunque, in gran numero hanno raggiunto la notorietà, da Pirandello a Sciascia, da Tomasi di Lampedusa a D’Arrigo, da Vittorini e al già citato Bufalino, da Borgese a Samonà, da Brancati a Consolo, da Quasimodo a Cattafi, a Piccolo, a Fiore, a Bonaviri, a Perriera e a tanti altri, così tanti che ricordarli tutti equivarrebbe a recitare una sorta di litania lauretana o le denominazioni coraniche di Dio. Il quarto convegno ha slargato il campo d’indagine, rivolgendo l’attenzione alla grande letteratura del resto d’Italia, da Svevo a Buzzati, da Carlo Levi a Silone, da Pomilio a Corrado Alvaro, da Ungaretti a Montale, da Saba a Caproni, da Pasolini a Tondelli, anche in questo caso per citarne solo alcuni. Il quinto convegno ha segnato una sorta di giro di boa, giacché – intendendo la scrittura letteraria come una «spada a doppio taglio» (Eb 4,12) – ha studiato il tema delle domande radicali in alcuni scrittori del Novecento che hanno espresso nelle loro opere i moti della loro coscienza problematicamente e, se si può dirlo, laicamente credente, e in alcuni spirituali che hanno saputo testimoniare la loro personale vicenda religiosa tramite una scrittura di “qualità letteraria”: per fare un esempio, il siciliano Fortunato Pasqualino a rappresentare i primi e don Primo Mazzolari a rappresentare i secondi.
Il convegno di quest’anno vuole approfondire proprio quest’altra direttrice della ricerca sulle domande radicali nella letteratura italiana contemporanea, registrandole stavolta come fossero “echi” di quegli interrogativi alti e puntuti che si trovano già nelle Sacre Scritture, a partire dal salmo 8, in cui l’orante biblico si chiede – mentre pure lo chiede a Dio – chi sia veramente l’uomo, attraverso tutta la cosiddetta letteratura sapienziale, di cui Qohelet è il rappresentante più famoso, per giungere al libro di Giobbe, dove le disgrazie dell’uomo di Uz preannunciano quella che nella vicenda pasquale dell’uomo di Nazareth si sarebbe rivelata anche come una misteriosa “sconfitta di Dio”, per usare le parole che compongono il titolo di un denso volumetto di Sergio Quinzio.
Gli echi sapienziali nella letteratura italiana contemporanea sono colti dai relatori del convegno nelle pagine di autori che coprono tutto il Novecento – da Clemente Rebora a Luigi Santucci, passando attraverso Guido Morselli, Cristina Campo, Bartolo Cattafi (rappresentante di un nutrito drappello di poeti siciliani vissuti prima e dopo di lui, da Virgilio La Scola ad Angelina Lanza Damiani, da Calogero Bonavia a Castrense Civello e ad altri ancora viventi, come Giovanni Occhipinti, Stefano Vilardo e, più giovane di tutti, Antonio Di Mauro), Primo Levi, Margherita Guidacci, David Maria Turoldo, Agostino Venanzio Reali e il già ricordato Sergio Quinzio – o che, come nel caso di Mario Luzi, Divo Barsotti e Alda Merini, continuano a vivere e a scrivere fino alla prima decade del XXI secolo. Non c’è una finalità sistematica a collegarli insieme, ma il desiderio di saggiare almeno in ordine sparso un territorio del resto troppo vasto per essere perlustrato con una sola incursione. D’altra parte il percorso di lettura e di interpretazione risale volutamente più a monte e prende le mosse da Giacomo Leopardi, che dei «poeti del dolore» – per citare una relatrice del convegno, Anna Baldini – è in Italia il capostipite. Si tratta di autori che condividono più che la fede in Dio la pietà per l’uomo, nel cui nome essi alzano la voce per chiedere conto e ragione – all’uomo stesso e, in ultima istanza, a Dio – di ciò che l’opprime e lo mortifica. Proprio come Giobbe, che nel libro biblico a lui intitolato si smarca dalle teodicee che da sempre tentano pelosamente di giustificare Dio ad ogni costo di fronte ai mali dell’uomo e arriva finalmente a teologare, cioè a chiederne tragicamente il perché a Dio stesso.
Il convegno si propone di far emergere la corrispondenza intertestuale fra lettera biblica e produzione letteraria, senza fermarsi tuttavia a contare le citazioni bibliche più o meno esplicite ricorrenti negli autori presi in esame, o quelle soltanto implicite nascoste nelle loro opere, bensì concentrandosi a decifrare ciò che del messaggio biblico di volta in volta, caso per caso, l’eco prolunga e deforma al contempo. Insomma, ciò che – negli scrittori studiati – è “altro” rispetto alla lettera biblica, ciò che viene rielaborato e superato nel momento stesso in cui pure è recuperato e ricordato. Si vuole capire cosa diventa – e perciò cosa forse non è più – la preghiera del salmista, la meditazione di Qohelet, il cantico degli innamorati, la protesta di Giobbe, nei versi e nelle pagine di Leopardi e degli altri autori italiani qui chiamati in causa. Ci si propone, in definitiva, di appurare una intertestualità non meramente filologica, capace di svelare piuttosto la continuità-nella-discontinuità tra lo spirito del messaggio biblico e la ricerca di senso di cui si sono incaricati i nostri scrittori.
Per conseguire questo obbiettivo occorre innanzitutto riflettere sul carattere letterario delle Sacre Scritture e, in particolare, sulla qualità poetica della letteratura biblico-sapienziale, perlustrando così un orizzonte vastissimo che già pionieri come Robert Alter e Jean-Pierre Sonnet hanno negli anni scorsi indagato con grande efficacia pur senza esaurire le possibilità esegetiche ed ermeneutiche che se ne possono ricavare. Promettente e significativa risulta in particolare, a tal riguardo, la polisemia che le parole della lingua ebraica si portano dietro e dentro come una loro dote peculiare. Se ne era accorto anche Leopardi. Nello Zibaldone, difatti, il poeta di Recanati più volte sottolineava la semplicità strutturale e persino la primitività linguistica dell’ebraico, che – mancando di termini composti – non può vantare la ricchezza semantica e la raffinatezza retorica del greco e di altre lingue antiche. Nondimeno, nella Bibbia, il deficit si traduce in chance, perché le parole si forzano a dire più di ciò che esprimono in prima battuta, nascondendo sensi traslati e metaforici, stridendo tra di loro di volta in volta negli ossimori, nei merismi e nei paradossi che trapuntano le storie d’Israele, risuonando all’unisono «riso e lagrime», per dirla come Dostoevskij nei Ricordi della casa dei morti ripreso e commentato da Santucci nel suo saggio su Poesia e preghiera nella Bibbia, come alleluia gioioso ma anche come protesta arrabbiata nei salmi e, persino, come controversa bestemmia sulle labbra di Giobbe che discute di Dio con Dio: «Or dunque – concludeva Leopardi – non potendo quasi la prosa ebraica usar parola che non formicolasse di significazioni, essa doveva necessariamente riuscir poetica per la molteplicità delle idee che doveva risvegliare ciascuna parola (cosa poetichissima, come altrove ho detto)» (Zib. 3565). Così nella Bibbia l’afasia umana, che corrisponde e forse consegue all’indicibilità divina, viene in qualche modo guarita e addirittura guadagna dignità teologica. Ciò che non si riesce a dire, ciò che non si può dire, viene comunque udito, perché quello che è scritto, nel sua spesso disadorna semplicità, risuona di tanti diversi significati. «Se non fosse ambigua / mi piacerebbe meno la parola», viene da dire, ricordando un verso di Mariaceleste Celi. «Una parola ha detto Dio, due ne ho udite», dice lo stesso salmista (Sal 62,12), quasi ad ammettere che nella Bibbia ha capacità poetica – riesce a rintracciare il senso, si fa scopritore di significati – non tanto chi s’industria a discettare di Dio e, al limite, chi s’accanisce a discutere con Dio quanto piuttosto chi sa ascoltarlo: «Mi metto la mano sulla bocca. Ho parlato una volta, ma non insisterò; ho parlato due volte, ma non aggiungerò nulla», dice esausto ma consapevole Giobbe al cospetto di Dio, ormai nel finale del suo libro (Gb 40,4-5).
Stando così le cose, la letteratura biblico-sapienziale non subisce ma, anzi, si esercita nello sforzo ermeneutico. Ha da essere compresa, certamente. Ma è pure, già essa stessa, tentativo di capire. Alla stessa stregua di quella letteratura inquirente e questuante, gravida di domande radicali, che nel convegno viene presa in considerazione. In uno dei suoi ultimi componimenti poetici, il dramma dedicato al martire palermitano don Pino Puglisi (Il fiore del dolore, 2003), non a caso Mario Luzi fa dire al personaggio suo portavoce: «Nostro mestiere è l’interpretazione». Il poeta è, sulla scorta del salmista, o del Qohelet, o di Giobbe, non colui che teorizza ideologie, ma colui che interpreta lo svolgersi del mondo e, al limite, il dirsi e il darsi di Dio nel mondo stesso, sempre restando attento a ciò che non è ovvio, a ciò che rimane non evidente, dislocato sull’«altro lato della vita», come ha scritto Cristina Campo in una pagina de Il flauto e il tappeto.
Occorre quindi riflettere anche sulla letteratura contemporanea come ri-scrittura della Bibbia, intesa (la ri-scrittura) non come mera ripresa di immagini e di suggestioni bibliche, ma come ri-comprensione di quelle immagini e di quelle suggestioni. Il tema, a partire dalla lezione di Northrop Frye sulla Bibbia «grande codice» della cultura occidentale (1981), è ormai declinato da molti studiosi, anche se talvolta in direzioni differenti. I corposi volumi curati da Pietro Gibellini e da Nicola Di Nino su La Bibbia nella letteratura italiana (2009 e 2011), sotto questo profilo, sono esemplari e costituiscono un importante punto di riferimento. Nel nostro caso, però, si tratta di nuovo di inseguire specialmente gli echi sapienziali, non solo in autori come Turoldo e Reali, i quali hanno tradotto in poesia italiana intere sezioni della letteratura biblico-sapienziale, i Salmi in particolare Turoldo e il Cantico dei cantici Reali, ma anche in autori che hanno composto nuovi salmi o nuovi cantici rivestendosi – consapevolmente o senza neppure rendersene conto – dei panni del Qohelet, o di Salomone, o di Giobbe, o persino – slittando in avanti, verso Gesù di Nazareth – mettendosi nei panni degli evangelisti, sino a proporre anche loro – come Luigi Santucci con il suo libro Volete andarvene anche voi? – un “quinto evangelio”, nelle cui pagine incontrare ancora il Christus patiens, «gran piaga verticale» in cui ognuno può ormai riconoscersi e riconoscere Colui che assume la condizione di Giobbe e grida sulla collina del Golgota la protesta del salmista: «Perché mi hai abbandonato?» (Sal 21[22]), mentre si accinge a «baciare» la morte, divenendo perciò «uomo per eccellenza», come l’ha definito Alda Merini in un verso del suo Magnificat.
Le questioni radicali, emergenti dalla ricerca dei relatori del convegno, sono molte e varie, a cominciare da quella forse più estrema, la questione del «nulla», che attraversa la letteratura italiana dallo Zibaldone di Leopardi ai Canti ultimi di Turoldo, nel primo assumendo una principialità alternativa a Dio stesso, nel secondo una co-principialità che lo riconduce a Dio, a Dio rendendolo compatibile, con Dio identificandolo. Per parte mia, introducendo il convegno, vorrei segnalare la variante che della questione del nulla coglie Guido Ceronetti, un altro autore che a quelli elencati nel programma del convegno si può a buon diritto accostare, allorché parla del «vuoto» in cui, a suo parere, consiste il sacro biblico. Anche Ceronetti ha tradotto in poesia italiana i sapienziali antico-testamentari, lavorando direttamente sul testo ebraico: così ha fatto per i salmi, per il Qohelet, per Giobbe, per il Cantico dei cantici, per poi dedicarsi ad alcune importanti pagine del Nuovo Testamento, come il Pater noster insegnato da Gesù ai suoi discepoli. La questione del vuoto, secondo Ceronetti, emerge dal Cantico dei cantici, lì dove il sacro si può comprendere come «vuoto tagliente», luogo di Colui che non può essere-collocato, esclusione d’ogni sacrario che si proponga esplicitamente come tale, presenza di quel Dio che se c’è non può esserci che rimanendo da solo, l’Unico, mentre pure si contrae presso di Sé per far-esserci anche l’uomo. In questo senso il profano, il sensuale, il carnale, l’umano, troppo umano, soltanto umano, Cantico è davvero e totalmente sacro: «Dio nel Cantico non c’è, eppure Dio lo riempie». Il Cantico, dunque, è antropologia: non perché sia il corrispettivo ebraico del kamasutra indiano, una mera via per giungere all’esperienza del piacere, ma perché è, dicendolo al modo di Caproni, ateologia. Vale a dire l’unica parola che si possa proferire, ma udita due volte, secondo un suo primo significato e(p)pure secondo un suo significato-altro. Compiuta ri-velazione, svelamento e nuovo velamento: «Certo Dio ha voluto morire un poco nelle Scritture», è la conclusione sottolineata da Ceronetti.
La questione, in questi termini, è senza dubbio radicale. Ma si può radicalizzarla ancor di più, come del resto fa lo stesso Ceronetti, travasando il vuoto nel silenzio. Che è, poi, il paradossale tema giobbiano del convegno: al di là dell’ideologia, oltre l’elucubrazione di Dio azzardata dai tre amici di Giobbe, rimane il silenzio dell’uomo di Uz, spiraglio attraverso cui Dio può finalmente dirsi. Ceronetti contesta la posa teologica di quei tre a favore del gesto poetico di chi si mette la mano sulla bocca: «Sta qui il deicidio profondo, nella vertigine della sua consumazione: si uccide Dio facendolo conoscere; gridando a tutti – invece di far scendere goccia a goccia la rivelazione […] – la realtà e l’unità divina e l’incommensurabilità tragica della sua trascendenza rispetto a ogni creatura. […] Essere un nabì ebreo o un rasùl Allah, un profeto o un inviato, implica sempre un forte grado di colpa: perché profeti e inviati predicano, predicono, insomma parlano, e parlano troppo».
Concludo (per introdurre finalmente e davvero), permettendomi di citare un altro brano di Ceronetti, in cui la letteratura biblica più umana che ci sia, il Cantico appunto, è presentata proprio come quella che riassume e risucchia nell’alveo delle Scritture sante ogni altra umana scrittura: «Quante care immagini potrei, del vuoto divino, evocare! Divino vuoto non è anche nelle malinconiche anfore di Orazio, dove il vino è migliore delle carezze, e nel cadavere aperto dall’anatomista Deyman, che il sovrumano veggente Rembrandt mi mostra come un poema d’amore? E la spelonca di Montesinos, dove si cala Don Chisciotte e vede cose straordinarie, ma non ne rivela che pochissime – e la spelonca è deprimente e vuota per chiunque non sia il veggente della Mancha – non è il Cantico col suo segreto? E il vortice dello Strom. Dove precipita il pescatore di Lofoden, nel racconto di Poe, non è un’immagine di noche oscura? Discesa nel Maestrolm è discesa nella profondità uterina e nel vuoto di Dio […]. Un fantastico vuoto di Dio si spalanca nel viaggio dei tre personaggi di Verne al centro della terra, sotto il cono di un vulcano islandese, e nella balena di Pinocchio, e nella miniera di carbone di Germinal, favola sacra delle Fiandre operaie, senza le mandragore e i cervi, e come nel Cantico anche qui Dio è innominato, assente, tutto abolito. Sono viaggi nel Nulla; ma Dio continua a inviarci i suoi segni negativi, a coagulare mistero, e una luce schermata di noche oscura fa da battistrada a chi esplora. Tutto è Scrittura in movimento, l’illimitato e il continuo di un divino Apocrifo».
Il tenore di questa pagina può suonare per qualcuno, forse, un po’ gnosticheggiante. Ma anche per lui vale la regola che Divo Barsotti faceva valere per le bestemmie di Giobbe e di Leopardi: per intenderle veramente, bisogna ascoltarle con le stesse orecchie di Dio. Ci accorge così che sono anch’esse preghiera. E buona novella.
* Docente di Teologia sistematica nella Facoltà Teologica di Sicilia (Palermo)