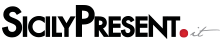L’occasione della beatificazione di don Puglisi è buona per chiederci quale rapporto si può intravvedere fra il “martirio civile” di uomini come Falcone e Borsellino – per fare un esempio – e il martirio cristiano di uomini come il parroco di Brancaccio: che hanno da spartire i testimoni delle nostre comunità ecclesiali con gli eroi di cui talvolta sentiamo la nostalgia? La domanda è tutt’altro che oziosa o capziosa. Si tratta di districarsi tra l’entusiasmo di chi li fa coincidere e la diffidenza di chi sospetta un’indebita commistione o una prevaricazione degli uni sugli altri. Tenendo conto del fatto che il cristianesimo ha di per sé un risvolto civile, in quanto è situato storicamente, dentro la “città” degli uomini, occorre comunque formulare una risposta che non dia adito all’inflazione del concetto cristiano di martirio estendendolo tout court ad ogni morte eroica possibile e immaginabile e, al contempo, non divarichi lo stesso martirio cristiano rispetto alla morte pazientemente e coraggiosamente subita da chi pratica valori importanti come la giustizia, la legalità, il bene comune, tutte dimensioni della promozione umana da cui la Chiesa contemporanea sa di non dover e non poter disgiungere il suo impegno di evangelizzazione e di testimonianza alla verità di Dio rivelatasi in Cristo Gesù.
Per la teologia è importante incaricarsi di rispondere a questa domanda, anche per svolgere il compito che a questo proposito le assegnò Giovanni Paolo II. Il papa polacco, già nel 1982, additò in san Massimiliano Kolbe un «martire dell’amore» più e prima ancora che della fede. E dalle colonne de «L’Osservatore Romano», il 7 ottobre 1982, proprio in riferimento a Kolbe un articolo non firmato – e appunto per questo, secondo qualche commentatore, ancor più autorevole – consegnò ai teologi l’impegno di ridisegnare «il profilo esatto del martirio moderno», per giustificare la scelta del pontefice, «forse non decantata appieno nelle scuole» e tuttavia necessaria per mettere i cristiani del nostro tempo nella condizione di riprendere in considerazione «con coscienza e coerenza la piena attualità del martirio». Da qui, negli anni successivi, venne sortendo una martirologia “inclusiva”, nella quale sono rientrati, secondo le indicazioni dello stesso Giovanni Paolo II, quelli che di volta in volta egli ha chiamato «martiri della carità», «martiri della pace», «martiri dell’ateismo» e, proprio in riferimento al sacrificio di uomini del Sud Italia come Livatino, don Diana e don Puglisi, «martiri della giustizia». Nuovi tipi di martiri e di martirii che sono riconducibili al motivo classico della fede professata dalla vittima e osteggiata dai carnefici proprio perché lasciano intuire efficacemente la circolarità teologale – con l’amore e con la speranza – in cui la fede stessa viene così vissuta più che semplicemente proclamata, al di là della sua accezione meramente dottrinale, dando luogo a tutta una serie di concrete azioni di giustizia che in certi contesti risultano, per chi non vive di Cristo, delle insopportabili e imperdonabili provocazioni e costituiscono l’intenzione radicale e il motivo fondamentale della martiría di chi testimonia – fino a patire la morte – la propria fedeltà a Cristo.
Salvaguardare la distinzione tra martirio civile e martirio cristiano senza esasperarla in distanza è, però, difficile. Per riuscirci bisogna ricomprendere il senso del martirio cristiano nel quadro della moderna secolarizzazione, la quale – nell’Occidente di antica ma svigorita tradizione cristiana – ha metabolizzato così a fondo le istanze evangeliche da giungere a concepirle quasi “naturalmente”, in termini ormai impliciti, non più consapevolmente riferiti all’esempio di Cristo. Si pensi allo slogan voltairiano – «Non la penserò mai come te, ma sono disposto a morire affinché tu dica il tuo parere» – che, mentre assimila l’insegnamento di Gesù secondo cui occorre porgere l’altra guancia e amare anche i propri avversari, rende paradossalmente superflua o almeno improbabile – in terre come l’Europa mediterranea – la possibilità di essere uccisi a causa delle proprie convinzioni religiose.
In realtà, in una tale temperie, il martirio non cessa di essere possibile e anzi “necessario” per continuare a segnare con tratti peculiari il volto del cristianesimo ecclesiale. Ma diventa urgente allargarne il senso, senza inflazionarne la qualità. Più precisamente diventa importante – ancor più che estendere il “concetto” di martirio – dilatare l’identità dei martiri, considerandoli come coloro che, oltre a dare la vita per un ideale e persino per qualcuno, muoiono “con” Qualcuno, venendo coinvolti nel martirio stesso di Cristo. Si badi bene: questo tentativo di smarcare l’identità dei martiri dal concetto del martirio non tende a divaricare e, al limite, contrapporre il martirio e i martiri, ma a distinguere debitamente il concetto dall’identità, la quale rispetto al primo ha un profilo certamente meno astratto, più marcato e radicale e, perciò, esistenzialmente più esigente. La nuova martirologia, così, passando dal tentativo di estendere il concetto del martirio al tentativo di dilatare l’identità del martire, passa pure dalla considerazione di un’idea e di un ideale, pur nobilissimi, alla considerazione di alcuni vissuti concreti, cui non applicare più – deduttivamente – un’etichetta teologica, ma da cui piuttosto ricavare – induttivamente – una teologia della testimonianza cristiana.
In questa prospettiva sono andate le riflessioni – pur differenti – di teologi come Balthasar e come Rahner o di alcuni latino-americani come Ellacuría e Jiménez Limón, d’accordo nell’ammettere che chi viene ucciso perché professa la fede cristiana non può non morire per la sua fedeltà a Cristo vissuta nella pratica della verità e della giustizia: così come è stato nel caso paradigmatico della martiría di Gesù stesso, costitutiva di ogni altra autentica e compiuta martiría. In tal modo si arriva a comprendere – come aveva già capito nel medioevo san Tommaso e come ha gridato Giovanni Paolo II ad Agrigento nel 1993 – che il martire cristiano non è soltanto chi dà la vita a motivo della fede, come il martire civile non è soltanto chi viene ucciso per la giustizia. Anche il martire cristiano, in fedeltà a Cristo, può morire per la giustizia. E anche il martire civile può ritrovarsi associato a Cristo – modo Deo cognito, potremmo dire con GS 22 – mentre si sacrifica per la giustizia.
Per guadagnare quest’intelligenza teologica del martirio cristiano è necessario ricomprendere sub evangelii luce, sulla scorta della lezione del Vaticano II, tutte le sue dimensioni: quella umana, come dimensione radicalmente morale sormontata e insieme visitata da Dio, a lui ricondotta perché da lui sostenuta; quella credente, incardinata non solo nella fede creduta (fides quae, potremmo dire con la teologia classica) ma anche nell’atto di fede (fides qua), vissuto in teologale circolarità con la speranza e con l’amore; quella ecclesiale, nella quale diventa visibile e significativo anche di fronte al mondo ciò che è visto da Dio. Si tratta di un’ermeneutica specificamente cristiana, che può farci rendere conto che il martirio di chi è discepolo di Cristo è – in taluni contesti – proprio il martirio del “giusto”, illuminato però dal vangelo.
Mi pare si possa cogliere anche in questo caso l’intreccio tra la carne e lo Spirito in cui consiste – nel solco dell’Incarnazione – ogni autentica vicenda cristiana: lo Spirito è sempre nella carne, così come è sempre nella lettera del vangelo, mai a prescindere da essa.
Per ricostruire e raccontare attendibilmente la vicenda di uno spirituale, difatti, bisogna prendersi carico di una particolare dialettica: quella tra continuità e discontinuità. Continuità: cioè stretta connessione, inevitabile influsso reciproco, interdipendenza tra l’individuo e l’ambiente sociale cui questi fa riferimento, tra il singolo credente e la comunità ecclesiale di cui è membro. E discontinuità: cioè capacità – in obbedienza a Dio – di eccellere rispetto a quel medesimo ambiente di riferimento, di emergere in e da quella stessa comunità di appartenenza.
Uno spirituale non cessa mai d’essere situato nella storia comune degli uomini: egli è e rimane impastato dell’umanità che condivide con coloro che vivono assieme a lui, nel posto e nel tempo in cui egli stesso vive e opera. E, tuttavia, è anche toccato da Dio, interpellato, raggiunto, guidato dal suo Signore, che intrattiene con lui un rapporto “grazioso”: gli si dona, dimora presso di lui, inabita in lui. In questo senso l’esperienza spirituale è innanzitutto l’azione di Dio nell’esistenza dello spirituale, il quale è tale in quanto resta docile alla Presenza dello Spirito Santo in lui. La spiritualità dice, appunto, il primato e la priorità dell’iniziativa divina nei confronti di un uomo, eletto ad un rapporto di stretta amicizia con Dio: è la vita dello Spirito di Dio in quell’uomo, il quale così è pure messo in condizione di vivere secondo lo Spirito, di adeguare cioè la propria vita a quella di Dio che viene a vivere con lui. Ciò può accadere, come è spiegato nella Lumen gentium n. 40, per tutti, senza esclusione: la vocazione alla santità è universale. Ma questo non avviene in tutti allo stesso modo: ognuno, per il luogo e l’epoca in cui vive, per le condizioni in cui si trova e per i condizionamenti positivi o negativi che riverberano su di lui proprio da quelle condizioni, per la sensibilità personale che ha, per la configurazione caratteriale, psicologica e intellettuale che ha via via assunto, per la formazione culturale che ha maturato, per tanti altri fattori “umani”, ma anche e soprattutto per il particolare carisma pneumatico ricevuto “in dote” dal Signore, ascolta la chiamata all’amicizia con Dio in maniera peculiare; e risponde in termini ancora una volta molto specifici. Se è vero che Dio chiama tutti, non tutti però sentono, o non tutti rispondono; e non tutti sentono e rispondono allo stesso modo.
La vicenda di uno spirituale, anche quella di un martire, vista in questa prospettiva, appare come una sorta di matassa, arrotolata di fili diversi ma legati assieme: per dipanarla occorre discernere tra i vari fili senza compromettere i nodi che li stringono insieme. Si tratta di distinguere senza distanziare ciò che – di epocale, di sociale, di culturale, di ecclesiale persino – accomuna quello spirituale, nel nostro caso il martire don Puglisi, agli altri suoi contemporanei e ciò che – di grazioso, di carismatico, di pneumatico – costituisce la radicale novità del suo modo di lasciarsi incontrare da Dio.
Ecco perché in questo convegno sondiamo la peculiare maniera con cui don Puglisi attinse dal messaggio biblico e dal vangelo le ragioni della sua scelta a proclamare i “diritti di Dio”, come già il Servo di Jhwh e come Gesù stesso (ce ne parlerà il prof. Giuseppe Bellia, nostro docente di teologia biblica). E verifichiamo il suo metodo della “tenerezza” quale “arma impropria” per resistere evangelicamente alla mafia (come ci spiegherà il prof. Giuseppe Anzalone, preside dell’Istituto Teologico Diocesano di Caltanissetta, che quest’anno ha tenuto qui da noi un corso su questo tema), mentre pure riscopriamo un interessantissimo progetto pastorale, pensato e anzi calibrato appositamente per la parrocchia di Brancaccio dallo stesso don Puglisi, che ne aveva disegnato personalmente i contorni e i profili, decidendone le finalità e persino la portata, che nelle sue intenzioni e speranze doveva avere la lunga gittata dei decenni e la forza di cambiare in positivo il volto di quel suo quartiere (ce ne parlerà il prof. Angelo Romano, che insegna storia della Chiesa a Roma, presso l’Università Urbaniana), per approdare infine alla riflessione sintetica e sistematica del prof. Cosimo Scordato, nostro docente di teologia dogmatica, sul senso del martirio sperimentato “in odio al vangelo” da un uomo mite e vero come don Pino.